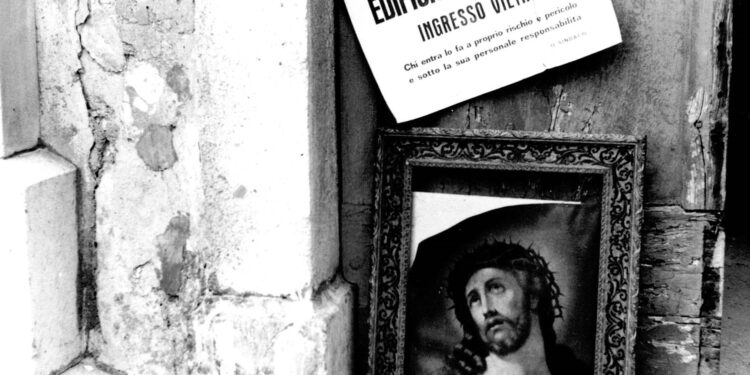“Nell’attuale contesto di infodemia, lo sviluppo di un’algoretica deve andare di pari passo con il discernimento di fake news e post-verità, imparando per esempio a capire che anche nel doomscrolling un deepfake influenza la nostra percezione della realtà”. Fermi tutti. Se non avete capito nulla di questa frase iniziale, con così tanti neologismi da far paura al dizionario Treccani, non c’è problema: significa che anche voi siete in balia delle onde del mare dell’informazione che ci sta travolgendo da quando i social media hanno fatto la loro comparsa, quasi vent’anni or sono. Eppure è un mare (anzi: un oceano) in cui è sempre più necessario saper navigare, onde evitare di restare sommersi dall’informazione o, viceversa, tagliati fuori dal mondo. È la professoressa Veronica Neri, docente di Filosofia morale ed Etica dei media all’Università di Pisa, a offrirci una “carta nautica” per la navigazione del web di oggi. Neri sarà ospite all’ultimo incontro dell’anno della Scuola di politica ed etica sociale (SPES) lunedì 26 maggio a Udine.
Professoressa Neri, l’incontro del 26 maggio sarà intitolato: «Siamo vittime delle piattaforme?». Si può davvero parlare di “vittime”?
«Il titolo è chiaramente provocatorio. La tecnologia in generale non è mai neutra e nemmeno quella delle piattaforme online, sempre più utilizzate anche dai giovanissimi. Direi che possiamo diventarne vittime se smettiamo di vigilare con consapevolezza. È chiaro che a volte ci possiamo imbattere anche in situazioni poco chiare, in cui rischiamo di rimanere invischiati perché le piattaforme cercano di creare relazione e monetizzare la nostra attenzione. Eppure, noi non siamo solo consumatori, ma persone capaci di compiere scelte responsabili e consapevoli. Quindi sì, possiamo subire certi meccanismi, ma in quanto soggetti morali dobbiamo e possiamo essere responsabili per dire “questo mi aiuta a crescere, a creare buone relazioni, questo no”.»
Parlavamo di “infodemia”, un enorme sovraccarico di informazioni. Un tema sempre più pressante, peraltro con molte notizie false o mezze verità… Come restare a galla nel mare delle informazioni?
«È una sfida che richiede di rallentare per discernere le informazioni con maggior consapevolezza. L’infodemia è, appunto, un’overdose di informazioni, quindi serve la capacità di leggere la realtà e l’informazione con profondità, a volte anche lasciando sedimentare quello che leggiamo e sentiamo: non reagire subito, ma cercare di coltivare il silenzio e l’ascolto.»

C’è poi il tema della verità, un valore etico fondamentale anche sui media. Sempre più spesso – è capitato anche con una recente presunta citazione del nuovo Papa Leone XIV – sui social diventano virali contenuti del tutto inventati, anche se a fin di bene. Dove sta l’inghippo?
«Il problema è che la verità non si manipola nemmeno a fin di bene. È ciò che risponde ai fatti quindi non possiamo giustificare la diffusione di falsità nemmeno in presenza di buone intenzioni: si rischia di scivolare in un relativismo che può essere pericoloso. La verità va cercata, va indagata, vanno raccolte le fonti. Anche per questo ci vuole tempo, quindi di fronte alla comunicazione vale di nuovo l’invito a rallentare: indagare la verità richiede tempo, è assolutamente necessario.»
Parliamo della comunicazione politica, che dovrebbe essere istituzionalmente impeccabile, ma spesso “sdogana” una narrazione parziale, una comunicazione fuori luogo, toni urlati e contenuti faziosi. Perché?
«La comunicazione politica pur di farsi notare prende in prestito sempre più spesso gli strumenti della comunicazione pubblicitaria; come per la verità, dove la notiziabilità cerca di prenderle il posto (il cosiddetto “effetto verisimiglianza”), così la comunicazione politica trasforma l’arena comunicativa in un palcoscenico dove si recita una performance. Invece si dovrebbe tornare all’etimologia della parola comunicazione: “mettere in comune”. Il “cum” relazionale è dare qualcosa in dono richiedendo una reciprocità.»
Guardando a come sono fatti questi software, alcuni studiosi parlando di algoretica, ossia uno sviluppo etico di software e piattaforme social. È un obiettivo verosimile in un contesto globale e multipolare?
«È sicuramente un obiettivo doveroso: dobbiamo creare tecnologie che abbiano alla base dei principi etici. E questo vale sia per i social media, ma anche per l’intelligenza artificiale che peraltro sta alla base degli algoritmi dei social. Per gli sviluppatori si parla di “ethics by design” come base del disegno della tecnologia; “redress by design”, cioè ricalibrare eticamente lo strumento durante il suo funzionamento; “ethics in design”, che è più generale. I principi etici devono assolutamente essere alla base altrimenti rischiamo di creare qualcosa che ci fa del male.»
Quali sono tali principi?
«Primo è la beneficenza: lo strumento tecnologico, cioè, deve fare del bene e non fare del male (non maleficenza). Poi l’autonomia del software, la sua “giustizia”, la sua esplicabilità. Sono criteri regolamentati anche dall’Ai act europeo sull’intelligenza artificiale.»
Tutti noi abbiamo in mano uno smartphone o siamo davanti a uno schermo. Come “ci si allena” a una buona presenza etica sui media digitali?
«La consapevolezza è il primo aspetto: significa cercare di avere cognizione dell’uso dei social, sia nell’immettere contenuti (facendo attenzione a ciò che si pubblica) che nella fruizione. L’altro aspetto è legato alla società: ci vuole un’educazione alle tecnologie da parte di tutti, dalle scuole alle famiglie, per sviluppare una capacità di comprensione di questi strumenti. Questo porta a una corresponsabilità di tutti gli attori in gioco, da chi sviluppa le piattaforme al mondo della pubblicità fino alle persone che ne fanno uso. Infine, il tempo. Cercare, cioè, di darci il tempo di leggere, di ascoltare, di ragionare su come si usano certi strumenti per cercare di esserne pienamente consapevoli.»
Con Veronica Neri l’incontro finale della SPES
L’incontro conclusivo dell’edizione 2024-2025 della Scuola di Politica ed Etica Sociale, con la prof.ssa Veronica Neri, avrà luogo lunedì 26 maggio alle 18.15 al palazzo Garzolini-Di Toppo-Wasserman di via Gemona 92 a Udine. Possono partecipare anche uditori non iscritti all’intero percorso della SPES, scrivendo una e-mail a spes@diocesiudine.it. In virtù di un accordo tra la SPES e l’Ufficio diocesano per la pastorale delle comunicazioni sociali, all’incontro sono invitati in modo particolare operatori e operatrici dell’ambito “Cultura e comunicazione” delle Collaborazioni pastorali, oltre a tutte le persone interessate al tema.
Giovanni Lesa