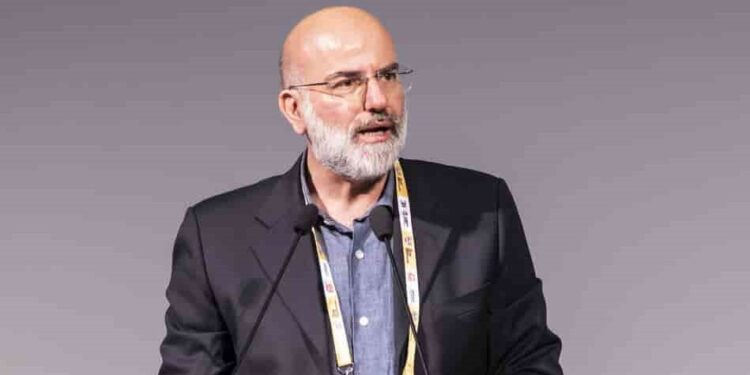«Ci impegniamo a essere “case della pace” e a promuovere – nei nostri territori, con i giovani, le famiglie, le scuole – proposte di educazione alla nonviolenza, iniziative di accoglienza che aiutino a trasformare la paura dell’altro in occasioni di scambio, momenti di preghiera e attività che favoriscano la cultura dell’incontro, del dialogo ecumenico e interreligioso, del disarmo e della solidarietà». Così recitava l’Appello per la pace delle Chiese in Italia, Slovenia e Croazia siglato a Gorizia lo scorso 23 settembre dal cardinale Zuppi, presidente dei Vescovi italiani, con gli omologhi di Slovenia e Croazia. Sono diverse, dunque, le direttrici su cui la Chiesa italiana fa la sua parte per la costruzione della pace: educazione, dialogo, preghiera e appelli ai governanti.
Una declinazione, questa, che trova casa anche sul territorio friulano, da sempre crocevia di popoli ma non per questo scevro da possibili rimbalzi di violenza e intolleranza. La strada dell’educazione è solcata da diverse iniziative, una delle quali è l’edizione 2025-2026 della Scuola di Politica ed Etica sociale, che parafrasando un celebre motto latino è intitolata, quest’anno, «Si vis pacem, para pacem» (Se vuoi la pace, prepara la pace). Ad aprire i lavori sarà Sabino Chialà, priore della comunità ecumenica di Bose, ospite giovedì 16 ottobre all’evento inaugurale della SPES.
Sabino Chialà, partiamo dal titolo del suo incontro a Udine: «Riflessione sulla natura del potere». Da dove ha origine il “potere”?
«Il potere è una realtà che ci abita in quanto è legata alla vita, lo esercitiamo in varie forme. Ed è una realtà ambigua: può avere un aspetto luminoso, ma neanche uno tenebroso. Il termine stesso normalmente ha una connotazione negativa, potremmo dire che è figlio della nostra inclinazione a dominare, un riflesso del nostro istinto di sopravvivenza. Tuttavia, il potere ha anche una declinazione positiva, infatti utilizziamo spesso un termine analogo, ma con una coloratura diversa: autorità. È curioso che nel Nuovo Testamento il termine, in greco, è lo stesso».
Dal potere (o dall’autorità) spesso nascono conflitti con la società. È possibile “gestire” un conflitto?
«Passiamo la vita a gestire conflitti. Ne gestiamo a più livelli, da quelli interiori (non dimentichiamo che le disarmonie hanno una loro radice sempre nella nostra interiorità), a quelle con le persone con cui viviamo, a quelli su larga scala, a livello sociale ed ecclesiale. E quindi dobbiamo gestirli.»
In che modo questo è possibile?
«A mio avviso la via è sempre quella di riportare il conflitto alla sua radice, cioè a ciò da cui nasce. Parlavo della disarmonia interiore che spesso si manifesta anche in una disarmonia esteriore: un errore che di solito facciamo è voler gestire i conflitti alla superficie, senza riportarli alla loro radice: è lì che va affrontato il conflitto.»
Può farci un esempio?
«Dobbiamo imparare ad agire e non a reagire, che invece è qualcosa che facciamo d’istinto. Dinanzi a un contenzioso, a una contraddizione, la nostra risposta è spesso una reazione. È invece necessario sapersi fermare, ripensare a ciò che è accaduto e, magari, provare a non farsi determinare nella nostra risposta dal male che abbiamo subito.»
L’intervista integrale, a firma di Giovanni Lesa, è pubblicata sul numero de La Vita Cattolica dell’8 ottobre 2025.