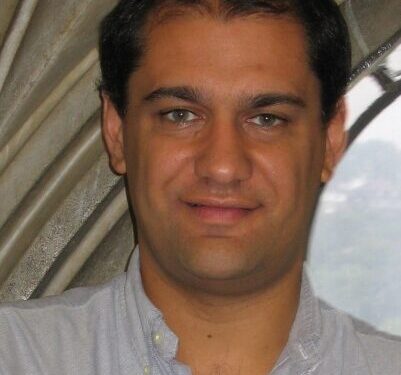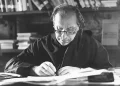Difesa, sicurezza, industria, commercio: i problemi che insorgono in questi ambiti mostrano che gli Stati europei non possono restare isolati sullo scacchiere globale, privi del supporto delle istituzioni europee. Inoltre, sono ambiti che presuppongono politiche generali comuni e richiedono, quindi, un ulteriore sviluppo dell’integrazione europea.
D’altra parte, molti sono scettici sulle istituzioni europee. Talvolta le critiche sono mal poste. Nel caso del nostro “Tocai”, ad esempio, noi diamo spesso all’”Europa” la colpa del fatto che non possiamo più usare lo storico nome del nostro vino bianco preferito: in realtà, non abbiamo saputo utilizzare gli accordi internazionali per avere l’esclusiva di quel nome o almeno per poterlo condividere con gli ungheresi. Inoltre molti critici sembrano dimenticare tutte le situazioni nelle quali beneficiamo quotidianamente delle politiche europee: pochi sanno che il treno Micotra che collega Udine e Villaco può esistere solo grazie a un finanziamento europeo. E’ comunque vero che in certi casi le politiche europee sono davvero criticabili: possono trascurare gli interessi di alcuni o restare sorde alle istanze di altri.
Corrette o meno che siano, le critiche non giustificano la perdita di fiducia nelle istituzioni europee, ma mostrano che è necessario conoscere meglio tali istituzioni, anche per poterle migliorare. L’integrazione europea è un processo in corso e l’esito non è scontato, né determinato dall’esterno. Sta a ciascun individuo, a ciascun gruppo, a ciascuna comunità parteciparvi. Se le parti sapranno fare sentire le proprie voci, le istituzioni cresceranno capaci di perseguire il bene comune, inteso come un fine d’azione che tutte le parti coinvolte possono riconoscere come ragionevole.
Ma è possibile procedere nell’integrazione politica in Europa? Perché un gruppo di individui sia una comunità politica, quegli individui devono condividere una certa identità, ossia un insieme di pratiche che permetta loro di riconoscere l’autorità delle medesime istituzioni. Quando prevaleva la concezione dello Stato moderno, basato sulla sovranità, molti sostenevano che l’identità politica dovesse essere necessariamente nazionale. Com’è noto, per Manzoni, l’Italia doveva essere «una d’arme, di lingua, d’altare, di memorie, di sangue e di cor»: l’identità politica era intesa come un’immaginata (e immaginaria) identità nazionale. Quel modo di intendere l’identità politica ha mostrato i suoi limiti negli esiti totalitari del Novecento. Nel dopoguerra si è sperato di risolvere il problema con le liberal-democrazie, che si basano su una concezione procedurale dell’identità politica, per cui è cittadino chiunque sia così definito dalla costituzione. Tuttavia, questa soluzione lascia perplessi: un gruppo eterogeneo di individui qualunque può diventare una comunità politica solo perché si assegna lo status di cittadini ai suoi membri? Le liberal-democrazie europee contemporanee non sembrano reggersi davvero solo sulla concezione procedurale della cittadinanza, ma sembrano alimentarsi da presupposti nazionali ancora esistenti: sulle loro unità interne giocano ancora molto i retaggi della storia precedente.
Cos’è l’identità politica, se non deve esser un’identità nazionale e se non può essere solo un’identità procedurale? La risposta può aiutarci a comprendere se e come possa essere integrata politicamente l’Europa. Il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine svolge ricerche anche su questo tema, per esempio nell’ambito del progetto Identità politica europea: governance e razionalità pratica di fronte alle sfide multiculturali. Dal punto di vista didattico, il Dipartimento offre la laurea magistrale in Cittadinanza, istituzioni e politiche europee, che prepara proprio a sfruttare le opportunità della cittadinanza europea e a interagire con le istituzioni europee per migliorare la rappresentanza delle esigenze locali. Nell’ambito di queste attività, il 20 e 21 novembre, si terrà un convegno scientifico in inglese sui futuri possibili dell’identità politica europea. In programma ci sono anche una tavola rotonda pubblica in italiano e una mostra del pittore Maxim Kantor, che da molto riflette sull’Europa.
La meta di queste attività è comprendere come si possa costituire un’identità politica europea: non possiamo pensare di costruire un nazionalismo europeo, ma non possiamo neanche pensare che l’identità politica europea esista solo perché c’è una dicitura sul passaporto. Nel progettare una casa dobbiamo conoscere bene il materiale che abbiamo a disposizione. Nel progettare l’Europa del futuro dobbiamo pensare a come i suoi membri siano diventati ciò che sono nel corso delle loro storie e a come possano sentirsi parte di un contesto più ampio nel quale, senza vedere negate le proprie identità, possano riconoscersi in istituzioni capaci di coordinarli in vista del bene comune.
Gabriele De Anna
Università di Udine