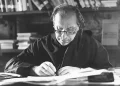La nostra quotidianità è accompagnata da una moltitudine di dati. Numeri predisposti da soggetti diversi (Istat, Centri di ricerca, Agenzie finanziarie, Regione) che riguardano tutti gli aspetti dell’ambiente, della nostra vita e del lavoro. Spesso accompagnati da resoconti che ci raccontano l’evoluzione passata delle varie situazioni considerate.
Assai di meno ci vengono presentati gli scenari e lo spettro dei futuri (al 2030, al 2050, al 2070, al 2100 né, tantomeno, vengono forniti con una certa assiduità strumenti per immaginare e predisporre strategie. Eppure di questo abbiamo bisogno.
Nessuno ci racconta che il Friuli è pienamente coinvolto da trasformazioni globali di natura geopolitica e da nuove dinamiche geoeconomiche, geotecnologiche e, da ultimo, geologistiche che determinano impatti notevoli sull’economia e sulle possibilità delle imprese di presidiare efficacemente vecchi e nuovi mercati. Così, dai dazi statunitensi fino alle capacità straordinarie espresse dal “nuovo mondo” (Cina, India, Kazakistan, Pakistan, Iran e molti altri) di produrre, innovare e di gestire le risorse naturali, l’economia marittima e la logistica, si generano cambiamenti rilevanti che influiscono sul nostro futuro.
Le trasformazioni di scala globale ci costringono a ripensare ai tradizionali modelli di produzione e consumo ed oggi incidono negativamente, ad esempio, sull’export dell’Italia verso gli Stati Uniti per 38 miliardi, sull’export regionale (sceso del 15%, da 22,2 miliardi a 19).
Senza dimenticare la riduzione del 4% della produzione manifatturiera penalizzando, in modo particolare, la nostra siderurgia, meccanica, agroalimentare e il mobile-arredo e ridimensionando le attività industriali connesse con alcuni settori, come nell’automotive dove si è assistito alla chiusura di numerosi impianti, al trasferimento di importanti produzioni come Iveco in Turchia e al presentarsi di criticità finanziarie come nel caso della Magneti Marelli di Amaro. Lo stesso sistema metalmeccanico (da Udine a San Giorgio di Nogaro, da Codroipo a Maniago) è stato – ed è – oltremisura condizionato dall’aumento dei costi dell’acciaio, alluminio e della ghisa, mentre l’economia marittima e le attività dei porti regionali risentono delle trasformazioni geologistiche specie nel comparto container e transhipment.
Come se non bastasse già questo scenario, che si sta contemporaneamente aggravando e consolidando, sono pochi quelli che ci ricordano che i nostri sistemi locali ed economie sono attraversate da intensi fenomeni strutturali (cambiamento climatico, regressione demografica con i riflessi sul calo delle nascite, invecchiamento della popolazione e sulla riduzione della componente femminile, fuga dei giovani e competenze, migrazioni e difficili processi di integrazione delle culture), alcuni dei quali sono certamente destinati a permanere al 2050 e al 2070.
La regressione della popolazione si prevede del 6% al 2050 e dell’8,3% al 2070 accompagnata dalla riduzione della componente attiva rispettivamente del 20% e del 24%: simile tendenza influirà in modo robusto sull’organizzazione e sulle modalità di fornitura dei servizi rivolti alla salute, all’educazione e istruzione, alla mobilità. Il trasferimento all’estero di donne e giovani specie laureati, cresciuto del 190% nel decennio, non solo è accompagnato da modesti livelli di compensazione dei flussi in entrata e uscita ma alimenta costi per circa 300 mln €/anno in termini di perdita di capitale umano e riduzione della competitività delle imprese. Banca d’Italia ricorda che la contrazione al 2040 della popolazione in età lavorativa (classi d’età 15-64 anni) dal 62% al 55% comporterà impatti sull’economia e nemmeno l’azzeramento del differenziale di genere (13%) non basterebbe a colmare il calo delle forze di lavoro per mantenere in futuro il tasso di occupazione attuale. Dall’altra parte, l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro riferisce che per mantenere gli attuali livelli, entro il 2034 gli occupati dovrebbero aumentare di 45.000 unità (+8,5%) e il 2044 di 97.000 unità (+18%).
La diminuzione delle importazioni e le criticità del mercato interno rappresentano alcuni dei riflessi determinati dall’erosione del potere d’acquisto degli stipendi (- 9,3% nel corso degli ultimi anni), dal permanere dei bassi salari (in Friuli Venezia Giulia tra i più bassi del nord) e dall’ulteriore differenziale di reddito che penalizza le donne nella dimensione regionale ( – 8.800 €/anno). Il cambiamento climatico, come approfondito almeno dal 2018 da Arpa Fvg, assumerà nei prossimi anni una dimensione rilevante (+ 1.3°C – +5.3°C in inverno, + 2.5°C + 6°C estate) tale da influire sulla disponibilità di acqua e sulla produzione agricola fino a generare modifiche nei tradizionali comportamenti delle persone e al 2050 avrà un impatto negativo sul Pil per l’8,5%.
Scenari ed interdipendenze tenderanno a ridurre del 20% la nostra produzione del Pil e, dunque, oggi non è pensabile agire come se fossimo in una situazione ordinaria con una gran mole di risorse trasferite a soggetti e territori senza priorità rigorose e riconoscere quali impatti ci si propone di generare e a quale livello. Vi è l’urgenza, invece, di «anticipare», «reagire» e «adattarsi» alle trasformazioni globali e ai fenomeni strutturali attraverso policy pubbliche «ecosistemiche» in grado di traguardare il medio e lungo periodo.
Vi alcuni segnali in controtendenza rispetto all’usuale agire pubblico che riflettono sugli scenari per definire specifiche misure e azioni amministrative.
In particolare, mi riferisco Disegno di legge n. 59 «Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l’attrattività del territorio regionale», promosso dall’assessore Alessia Rosolen, e alla proposta di Legge «Nuovo Welfare Fvg», promossa dalla consigliere regionale Manuela Celotti, che si pongono proprio dal punto di vista di riconosce prima il contesto complesso entro cui si è destinati a vivere e le dinamiche future e, di riflesso, indicano quali siano le misure e azioni più appropriate.
L’auspicio è che anche gli interventi sul turismo e sul commercio tengano profondamente conto, per un verso, del cambiamento del clima e, per l’altro, sia dell’impoverimento delle piccole comunità locali dovuto alla regressione demografica sia delle condizioni del mercato interno e dei consumi connessi con il reddito e le diminuite capacità di spesa delle famiglie.
Maurizio Ionico
Urbanista