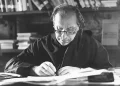La questione del calo demografico, in particolare in Italia, non è solo un dato statistico preoccupante, ma un grido silenzioso che interpella le nostre coscienze e la nostra visione del futuro. I recenti interventi sul Corriere della Sera di Maurizio Ferrera, Aldo Cazzullo e Cristina Comencini offrono spunti preziosi, seppur con prospettive diverse, su un fenomeno che affonda le radici in profonde trasformazioni sociali, culturali e, oserei dire, spirituali. Maurizio Ferrera, nel suo articolo “Le nascite in calo (e perché)”, analizza lucidamente le ragioni strutturali ed economiche dietro il fenomeno: precarietà lavorativa, costi elevati per l’educazione dei figli, mancanza di servizi di supporto. Elementi innegabili che rendono la scelta di avere figli un vero e proprio “salto nel vuoto” per molte giovani coppie. Questo quadro socio-economico, purtroppo, contribuisce a modellare una percezione della maternità e paternità non più come un naturale compimento dell’amore coniugale o un’aspirazione intrinseca all’essere umano, ma come “una delle possibilità”, equiparabile a molte altre scelte di vita.
Non sarebbe onesto però pensare che questa visione riduttiva sia solo figlia di fattori esterni. Un elemento cruciale è una cultura che, progressivamente, ha svuotato di significato la dimensione del dono di sé. I giovani, pur desiderosi di realizzazione personale, spesso vivono in un contesto che enfatizza l’autorealizzazione individuale in senso quasi esclusivo, dove il successo è misurato in termini di carriera, esperienze personali, viaggi, beni materiali. In questo schema, la genitorialità viene percepita non come un arricchimento, ma come una limitazione, un fardello che intralcia la corsa verso la soddisfazione dei propri desideri. I sacrifici che la genitorialità comporta – il tempo da dedicare, le notti insonni, le rinunce economiche, le modifiche ai propri ritmi di vita – non sono visti come parte di un processo di crescita e di amore, ma come ostacoli alla propria libertà individuale.
Aldo Cazzullo, con “Vero, fare figli non è un dovere sociale. Ma consigliare di averne non è paternalismo: ecco perché”, tocca un nervo scoperto. Se da un lato è sacrosanto affermare che la scelta di avere figli è libera e non può essere imposta, dall’altro è miope e pericoloso negare la dimensione sociale e comunitaria della natalità. Non si tratta di paternalismo, ma di un richiamo alla responsabilità verso il futuro della società e delle generazioni che verranno.
Ignorare il calo delle nascite significa accettare un futuro senza linfa vitale, senza la ricchezza di nuove idee, nuove energie, nuove visioni. Noi cattolici, in questo senso, possiamo ritrovare la forza dell’essere testimoni che la famiglia non è solo una realtà privata, ma la cellula fondamentale della società, e la procreazione è un atto che si inscrive in un orizzonte ben più ampio del mero desiderio individuale.
Il “non volere assumersi limitazioni” e il “concentrarsi solo sulla personale soddisfazione”, come si evidenzia, rischiano di sfociare in un vero e proprio individualismo egoistico. La Comencini, nel suo articolo “Il diventare madre è una scelta delle donne. Che oggi non sono egoiste ma semplicemente libere”, difende la libertà di scelta femminile, sottolineando come le donne non siano egoiste ma semplicemente esercitino un diritto sacrosanto. Tuttavia, la vera libertà, nella prospettiva cristiana e anche in una sana visione dell’uomo, non è l’assenza di vincoli, ma la capacità di scegliere il bene, anche quando esso comporta sacrificio. La libertà che si chiude solo in sé stessa, che non si apre all’altro, che non si fa dono, rischia di diventare una prigione dorata. La maternità, in questo senso, è una delle espressioni più alte della libertà che si fa dono, un atto di generosità che va oltre il sé per generare nuova vita e nuovo amore.
Secondo alcuni filoni di bioetica che mi sento di condividere, la vita nascente è un bene inestimabile, un mistero che merita accoglienza e protezione fin dal suo concepimento. La tendenza a considerare il figlio come un “diritto” da rivendicare o, specularmente, come un “peso” da evitare, denota una progressiva mercificazione della vita stessa. La scelta di non avere figli, quando motivata da una chiusura al dono della vita al fine di ricercare un mero piacere fine a se stesso, solleva interrogativi profondi sul senso dell’esistenza umana, nonché nel rapporto con Dio. Non si tratta di giudicare le singole scelte, ma di riflettere sulle radici culturali che portano a una tale disaffezione verso la genitorialità perché la natalitànonèsolounaquestioneprivata,maunfondamentodelbenecomune.Unasocietàche non genera vita è una società che invecchia, che perde dinamismo, che si avvia al declino. I giovani e le donne che scelgono di non avere figli, pur con motivazioni personali che possono essere comprensibili, contribuiscono, inconsapevolmente o meno, a un impoverimento del tessutosocialenelsuocomplesso.
In conclusione, la riflessione sul calo demografico ci interpella a più livelli. Non si tratta di colpevolizzare, ma di promuovere una cultura della vita, della generosità e del dono di sé. È un appello a riscoprire la bellezza e il valore intrinseco della maternità e della paternità, non come un peso o una limitazione, ma come una via privilegiata per la realizzazione piena dell’essere umano e per la costruzione di una società più giusta, più solidale e, soprattutto, più viva.
Cosa possiamo fare, per sostenere e incoraggiare le giovani generazioni a riscoprire la gioia e il valore di generare vita? Penso alla virtù della speranza in qualche modo motore della storia del mondo e delle nostre singole storie personali, quella che sembra essere “la più piccola delle virtù, ma la più forte” (Papa Francesco), che trasforma la realtà e dona forza nel cammino della vita, speranza che si nutre di futuro, e il futuro è fatto di nuove generazioni.
Elisa Gasparotto
Coordinatrice del Centro di aiuto alla vita di Udine