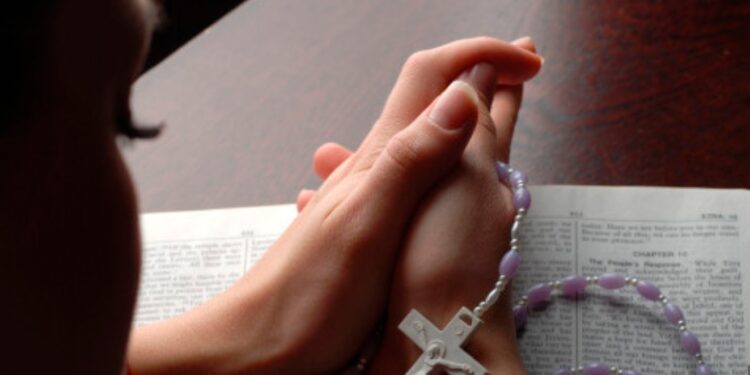Tutti ricordano la mobilitazione seguita alla mancata approvazione del Messale in friulano da parte della CEI nel novembre 2023, con la generale levata di scudi, rispettosa e convinta ad un tempo, contro questa occasione perduta; e, prima ancora, la massiccia adesione alla lettura continua della Bibbia in friulano nel 2011. A questi eventi, dove chiaramente l’emozione gioca un ruolo importante, non dovrebbe corrispondere un uso liturgico del friulano più costante e non eccezionale, accurato e appassionato, almeno dove la norma lo consente?
Se il ritardo della Chiesa circa l’approvazione del Messale è penoso, non lo è altrettanto quella pigrizia abbastanza diffusa, mescolata a forme di riguardo – non sempre adeguatamente ponderate – per chi non è friulano e potrebbe “non capire”: e non è questa inerzia a far sì che l’uso della lingua madre nella preghiera liturgica proceda sempre con il freno innestato? D’altronde, è onesto riconoscere la presenza di una maggiore consapevolezza del valore della lingua, così come di un uso stabile – almeno a livello diocesano – del friulano nella celebrazione; così come si registra, inoltre, un’accoglienza generalmente positiva della preghiera liturgica in friulano.
Forse nessuno più si straccia le vesti per una lettura biblica o un intervento omiletico in friulano durante la liturgia. Merito di un impegno diuturno e “resistente” di chi non si è stancato in questi decenni di operare da un lato a fare in modo che la questione della lingua nella liturgia non fosse percepita come un argomento di parte, ma come un tema ecclesiale e pastorale, e, dall’altro lato, di chi ha perseverato nella pratica, anche e soprattutto quando tutto sembrava remare contro. Merito di una Chiesa che ha saputo comprendere, come scriveva san Paolo VI nella Evangelii nuntiandi
al n. 63, che «l’evangelizzazione perde molto della sua forza e della sua efficacia se non tiene in considerazione il popolo concreto al quale si rivolge, se non utilizza la sua lingua, i suoi segni e simboli».
Capire, non capire o qualcosa di più?
La riluttanza di alcuni al friulano in chiesa è spesso motivata dal fatto che chi non conosce la lingua potrebbe non “capire”. Ora, premesso che il problema di per sé si pone ovunque ci siano persone che non conoscono l’idioma del luogo, e che molte volte esso viene lodevolmente risolto dalle stesse persone con retroterra migratorio acquisendo non soltanto la lingua ufficiale dello stato ma anche quella locale, c’è innanzitutto da chiedersi se il “capire” in liturgia sia una questione fondamentale, e se il ricorso alle lingue nella celebrazione dipenda da esigenze di comprensione dei contenuti. Il Vaticano II ha riproposto alla Chiesa la via maestra di una partecipazione al mistero nella liturgia, partecipazione che, se può essere anche consapevole, è innanzitutto actuosa, interessata all’azione, e “piena”, capace di coinvolgere anche la sfera affettiva.
La partecipazione incontra nella lingua madre una forma espressiva ed impressiva per nulla secondaria, in quanto codice “ricevuto” e non semplicemente appreso, strumento del sentire e non solo del dire, e dunque, canale privilegiato per accogliere ed esprimere la dimensione spirituale.
Al di fuori di questa visione, l’uso liturgico del friulano potrebbe sembrare superfluo, dal momento che oggi i friulani utilizzano e comprendono bene l’italiano e le altre lingue. In realtà, la parola liturgica, detta e cantata, tocca i corpi e i cuori, e insieme agli altri linguaggi, attiva la relazione con il mistero. Nelle celebrazioni, un ricorso alle lingue con finalità meramente didattiche non farebbe altro che svuotare la liturgia delle sue potenzialità e misconoscere la vocazione autentica di ogni lingua.

Un atto profetico
Papa Francesco più volte ha esortato a lottare contro la “cultura dello scarto” che umilia ed emargina soprattutto i piccoli e chi meno incide nello scacchiere del mondo. In un contesto mediatico sempre più massificante, che tende a mortificare ciò che è nativo (salvo poi ridurlo a pezzo da museo), la pratica della fede nelle lingue dei popoli risuona come opposizione e resistenza da parte della Chiesa a questa pseudocultura, dove ad essere apprezzati sono soltanto il profitto e il consumo.
In un’epoca in cui necessariamente gli scambi avvengono su scala planetaria, l’attenzione alle culture native è segno di civiltà e di promozione della dignità di ogni uomo, nella consapevolezza che nessuna lingua è piccola o scartata agli occhi di Dio. E l’atto di riappropriazione linguistica da parte di un popolo è il riconoscimento della varietà voluta dall’atto creativo di Dio
È significativo che l’Instrumentum laboris della XVI Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi (2023) abbia denunciato il colonialismo culturale che schiaccia le minoranze (n. 4) e abbia richiamato il compito della Chiesa di valorizzare la varietà delle culture senza costringerla all’uniformità (n. 25).
Infine, nell’epoca in cui le relazioni e le informazioni si avvalgono sempre di più del digitale, diventa necessario farne un uso che implichi sia la varietà e il pluralismo culturale, sia la disobbedienza allo standard globale che impone l’uniformità.

Quale friulano per la liturgia?
La pluridecennale esperienza celebrativa in friulano, attraverso la proclamazione di testi biblici, il canto e la preghiera, testimonia la vocazione della lingua materna ad essere ad un tempo codice del quotidiano e, quindi, non estraneo alla vita, e mediazione autentica e affidabile, capace di rivestirsi di bellezza e di grazia in vista della comunicazione e dell’esperienza del mistero. L’accurata traduzione della Bibbia prima – insieme con la pubblicazione dei Lezionari domenicali e festivi – e del Messale successivamente, in linea con una lunga consuetudine che ha determinato la traduzione dei testi biblici ad uso pastorale a partire dal XVIII secolo e la produzione di testi di preghiera, comprovano l’attitudine di questa lingua ad essere lingua cultuale, del tutto adeguata a esprimere temi teologico-spirituali e a rendere il linguaggio proprio della fede che si fa evocazione e invocazione, lode e supplica.
Questa prassi testimonia la “fattibilità” del friulano nella celebrazione e una sua disponibilità a essere trattato secondo le esigenze della liturgia. La recente versione in friulano dell’Inno del Giubileo e l’eco che essa ha avuto a livello nazionale conferma che dedizione e intelligenza, conoscenza della lingua e delle forme letterarie tipiche della preghiera, sono risorse indispensabili affinché la preghiera in marilenghe sia di qualità, impasto di terra e di cielo, come è tipico di ogni azione liturgica.
Il compito che ci attende
L’arcivescovo Riccardo Lamba, sulla scia dei predecessori, da tempo si è attivato affinché l’iter per l’approvazione del Messale giunga al fine desiderato. Un atto formale, necessario perché ribadisce la qualifica ecclesiale del libro liturgico, che ha bisogno della buona volontà di molti, non senza la caparbietà che i friulani sanno dimostrare, per far sì che la preghiera liturgica nella nostra lingua sia diffusa e non occasionale, e onori per qualità il mistero celebrato e la dignità delle assemblee che celebrano.
In fondo, è uno degli sforzi che le generazioni sono chiamate a fare quando vogliono difendere un bene essenziale per la loro vita e che la superficialità o la banalità potrebbero compromettere.
Mons. Loris Della Pietra