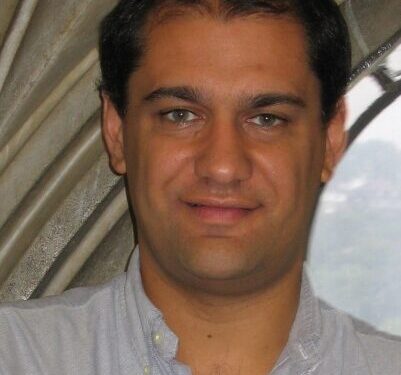Da alcune settimane sui principali giornali italiani una notizia trova largo spazio sia nelle pagine della cronaca sia negli spazi dedicati ai commenti, ossia il rifiuto di alcuni studenti liceali a sostenere la prova orale all’Esame di Stato. Il primo caso si è verificato a Padova, quando Gianmaria Favaretto ha dichiarato che non avrebbe fatto l’orale dell’esame «in quanto le valutazioni scolastiche non riflettevano la reale maturità dei ragazzi». A cascata gli episodi si sono replicati in altre scuole e ci spingono a delle riflessioni come educatori, adulti e genitori.
Chi vive nella scuola sa che l’Esame di Stato non si chiama più esame di maturità, ma viene identificato con la sigla ESC, perché è semplicemente l’ultima tappa del percorso di studi, quindi la valutazione finale non misura la maturità del ragazzo. Possiamo tranquillizzare tutti gli studenti e i genitori, dunque, ma ho sempre ritenuto interessante che i giovani continuassero ad usare la vecchia espressione, forse perché sentono il bisogno che gli adulti finalmente li considerino maturi. Per quanto riguarda il sistema dell’attribuzione dei voti, le varie riforme degli ultimi vent’anni hanno voluto valorizzare il percorso scolastico dei ragazzi ed evitare che i risultati delle prove d’esame pesassero troppo sul voto conclusivo. Si è quindi predisposto un sistema che attribuisce ad ogni studente, a partire dalla classe terza, un punteggio che per coloro che hanno avuto la media superiore al voto 9 nel triennio arriva a 40 punti. Le prove scritte valgono 20 punti ciascuna e le commissioni d’esame, una volta corretti gli elaborati, pubblicano il risultato degli scritti. A questo punto ogni studente è in grado di poter calcolare a quale punteggio finale può ambire, ma sa anche che, se ha superato i 60 punti, è promosso.
Evidentemente questo automatismo ha delle falle e sarà necessario che il legislatore modifichi qualcosa. Infatti se l’esame prevede che si sostengano delle prove scritte ed un orale, è necessario che l’allievo all’orale risponda alle domande, altrimenti si autoesclude da una valutazione, ma è chiaro che, come hanno fatto notare gli studenti, non basta presentarsi e sedersi davanti alla commissione, in quanto se il 60 è stato già conseguito nessuno lo potrà mettere in discussione.
Ritengo che questa vicenda stimoli almeno due riflessioni. La prima riguarda la forma di protesta. Questi studenti hanno contestato un sistema che rende la scuola sempre più competitiva, compagni di classe che si trasformano in schiacciasassi pur di mantenere medie alte, aspettative elevate da parte delle famiglie e degli stessi giovani con il serio rischio che coloro che non raggiungono il massimo dei voti si sentano dei falliti, pur avendo fatto un bel percorso scolastico. Se la scuola deve formare non solo lo studente, ma il cittadino, è evidente che questo modello non si concilia con una società solidale e attenta agli altri. Queste parole sono solo uno slogan se poi nella scuola non si creano contesti reali di collaborazione, di cooperazione e di dialogo e se per i nostri giovani tutto viene vissuto con ansia e competizione. C’è quindi dietro la protesta una richiesta di autenticità e di coerenza che i ragazzi rivendicano nel sistema scolastico. È anche vero che la forma di protesta scelta in fondo non prevedeva costi significativi da parte di questi studenti, perché erano promossi proprio in virtù dello stesso meccanismo che contestavano. Forse sarebbe stata più efficace, coerente e “matura” una prova orale sostenuta rispondendo alle domande della commissione e poi la richiesta di non registrare il voto, per protestare. Il rischio è che gli studenti che hanno svolto tutte le prove sentano che la società in fondo non è premiante se si rispettano le regole.
Il secondo elemento riguarda i segnali che i nostri giovani ci stanno lanciando con la richiesta di essere guardati veramente al di là di un voto, pur bello. Ormai da tempo si parla di un mondo giovanile in difficoltà, ma, citando il grande pediatra e psicanalista Donald Winnicott, «l’adolescenza è una “malattia” normale. Il problema riguarda piuttosto gli adulti e la società: se sono abbastanza sani per sopportarla», dobbiamo chiederci se siano i giovani in difficoltà oppure se questi episodi non parlino invece di un mondo adulto in crisi, incapace di essere un riferimento per i ragazzi.
prof.ssa Susi Del Pin