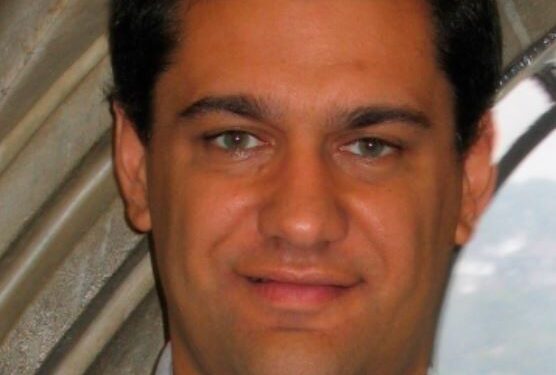“È difficile parlare di queste cose: quando sollevi qualche dubbio tutti pensano che tu li stia attaccando”. Uno studente mi ha fatto questa osservazione qualche giorno fa. Non so come lui la pensasse sul tema della discussione, che era il matrimonio (se esso possa essere eterosessuale, omosessuale, monogamo, bigamo o perfino poliamoroso); ma non è questo che interessa qui. In ogni caso, lo studente pensava anche ad altri argomenti accomunati dallo stesso destino di essere socialmente divisivi: l’aborto procurato, l’eutanasia, il suicidio assistito, per esempio.
L’affermazione dello studente mi pare interessante perché, da una parte, manifesta un disagio, ma dall’altra propone anche una spiegazione dell’origine del disagio. Il disagio è un senso di costrizione e di mancanza di libertà, per cui uno non si stente di dire apertamente come la pensa su certi argomenti. La causa identificata del disagio è che anche la semplice espressione di un’opinione su quegli argomenti viene vissuta da altri, o può essere vissuta, come un attacco, un’aggressione. Esprimere un’opinione su quei temi sarebbe quindi una forma di violenza. E nessuno di noi vuol esser ritenuto violento. Molti di noi non vogliono nemmeno sentirsi violenti.
Che al giorno d’oggi una persona si debba sentire a disagio nell’esprimere una propria opinione può sembrare paradossale. Non viviamo nell’epoca della libertà? I nostri ordinamenti liberaldemocratici non garantiscono il rispetto di tutte le opinioni? John Stuart Mill, uno dei padri fondamentali del liberalismo, aveva argomentato a favore della tesi per cui tutte le opinioni, anche le più assurde e ingiuste, dovrebbero poter essere espresse e discusse apertamente: solo in questo modo si può nutrire nel tempo le argomentazioni che confutano le posizioni assurde e ingiuste, e si può evitare che, prive di contradditorio, esse crescano e si diffondano in forme ideologiche e non argomentate. L’opinione di Mill, però, almeno nella sua forma pura, non ha retto alla storia del Novecento: come accettare che si sostengano apertamente le convinzioni dei nazisti, dei fascisti, dei brigatisti rossi, quando il dolore generato da quelle ideologie è ancora così vivo e presente nelle vittime o nei loro discendenti? La tesi di Mill è stata così attenuata: si deve poter discutere apertamente qualsiasi tesi, purché sia ragionevole.
A questo punto, però, il problema è stabilire quali siano i limiti della ragionevolezza. La causa del disagio rispetto all’espressione pubblica delle opinioni indicata dallo studente sembra proprio essere che opinioni che per alcuni sono assolutamente ragionevoli, anzi perfino giuste, ad altri paiono offensive e violente. Come trovare una quadra? Non basta certamente definire ragionevoli le opinioni socialmente prevalenti: in primo luogo, in questo modo nazismo e fascismo sarebbero state ragionevoli nei loro tempi, e questa conclusione pare assurda; in secondo luogo, rispetto ai temi socialmente divisivi di cui parliamo, alcuni vorrebbero cambiare proprio le prospettive prevalenti nella società, che ritengono irragionevoli perché le sentono oppressive.
Basandosi sulla dialettica elaborata da Platone e da Aristotele, la tradizione giuridica occidentale, nel corso della sua storia, ha sviluppato principi che permettono la discussione razionale di opinioni divergenti. Bilanciare quei principi per trovare soluzioni a problemi pratici che li rispettino tutti coerentemente è un’operazione che richiede la capacità di pensare in termini razionali, distanziandosi dalla propria emotività. E’ solo attenendosi a questi principi che un dibattito può dirsi pubblico, perché riesce a raggiungere quel valore unitivo che la vita politica richiede. Un dibattito è davvero pubblico, infatti, se riguarda la cosa pubblica, ossia se considera equanimemente le prospettive e le esigenze di tutti utilizzando metodi razionali idonei; non c’è invece un dibattito pubblico se alcune opinioni ragionevoli non trovano alcuno che osi esprimerle. In tal caso, non è sufficiente a rendere pubblico un dibattito il fatto che tutti possano assistervi o parteciparvi, per esempio, perché esso avviene in un luogo aperto (una piazza), in televisione, sui giornali, o su internet. Questi contesti, infatti, possono anche incentivare modalità di confronto basati più sulle emozioni che sulla ragione: si corre il rischio che i tempi di esposizione diventino troppo brevi per utilizzare ragionamenti complessi e che facciano presa soprattutto gli esempi ad effetto.
Gabriele De Anna
Università di Udine