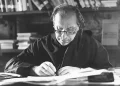I Vescovi a Benevento hanno esortato le istituzioni a definire nuovi percorsi di azione, coesione ed impegno comune per assicurare comunità vive e costruire in fiducia un avvenire delle aree interne e montane del Paese
Un messaggio forte, del tutto “politico” nella versione più alta e profonda del termine, che intravvede nell’abbandono di queste aree, nello spopolamento, nella fuga dei giovani, nella perdita di economie di prossimità, nel cambiamento climatico le principali sfide da affrontare attraverso il coraggio e l’unità d’intenti fra tutti i soggetti, pubblici, privati, reti associative e società civile.
Si tratta di un richiamo al tempo stesso autorevole e accorato che si rivolge ai credenti e non credenti per costruire in comunità d’intenti futuri possibili e desiderabili. Al fondo, la riflessione della CEI mette di fronte ad ognuno due modi per affrontare le questioni critiche: o considerale avversità cui, in qualche modo, porre rimedio, oppure occasioni per cambiare paradigmi, pensare e ri-progettare uno sviluppo armonico. Ecco, suggerisce la seconda strada, quella più creativa e generosa, quella destinata a “riaprire dei possibili” per dirla con lo studioso François Jullien.
Proprio i fenomeni che attraversano in profondità la montagna e le interdipendenze che determinano effetti complessi richiedono alleanze tra territori. Se si vogliono gestire i servizi ecosistemici prodotti in montagna e l’acqua, è urgente una relazione strutturata con la pianura e le città.
La pianura non è “altro” rispetto ai processi in corso nelle terre alte, e lascia stupiti come interi territori non si pongano il problema di come affrontare in modo compiuto difficili sfide, a partire dalla riproduzione e dall’utilizzo della risorsa idrica che li vede alla ricerca di sicure fonti di approvvigionamento per i loro bisogni quotidiani e per sostenere le attività produttive come l’agricoltura.
Serve un unico sguardo territoriale poiché i destini sono comuni. In questo senso, si rendono necessari una “strategia metromontana” ed un “forum di consultazione e concertazione”. Un patto per il futuro tra l’alto e il basso che permetta il buongoverno delle risorse e dei capitali territoriali e alimenti il confronto su demografia, clima e innovazione.
Questa impostazione comporta una revisione delle stesse modalità attraverso cui in montagna si pensano e progettano le soluzioni nei vari ambiti di attività. Va superata un’impostazione legata ai confini amministrativi e al prevalere del carattere “autonomo” delle pratiche ed iniziative intraprese, sia in termini di visione sia di progetto. Come se i fenomeni strutturali richiedessero di essere rinchiusi in spazi preordinati. Al contrario, la complessità richiede approcci ecosistemici e multiscalari. Far restare le persone, far arrivare famiglie e imprese, far ritornare i giovani e le donne impongono policy integrate e la dichiarazione di quali impatti (di breve, medio e lungo periodo) ci si propone di determinare. E di una fiscalità di vantaggio strettamente connessa con gli effetti puntuali che si vogliono realizzare. La montagna non è solo turismi transitori, richiede, invece, il radicamento di motori fondamentali per assicurare forza ai sistemi, come il consolidamento della dimensione produttiva e manifatturiera delle montagne, la costruzione di veri e propri ecosistemi dell’innovazione e la relazione tra “arte-creatività-manifattura”, che non rappresentano ancora una componente costitutiva delle direttrici di sviluppo armonico alla scala regionale.
Spes contra spem. La speranza contro la speranza. I dati riferiti ai diversi ambiti (demografia, natalità, clima, catene del valore, innovazione, migrazioni) consegnano scenari futuri (al 2030, al 2050) piuttosto controversi e assai critici. Ma, come indica la Cei, vi è il dovere e la responsabilità di coltivare ed assicurare struttura ai “possibili” e, in altro modo, disporre di un “pensiero lungo”. Le 1.200 persone che nel corso dell’ultimo triennio si sono insediate nei 58 comuni della montagna interna regionale rappresentano un fattore di fiducia, pur all’interno della regressione demografica e dell’invecchiamento della popolazione destinate a proseguire nei prossimi dieci anni. Si tratta di approfittare di questo segnale per far fuoriuscire la montagna dalla “trappola per lo sviluppo dei talenti” e da una situazione in cui risultano ancora frammentarie le “condizioni giuste” per permettere ai giovani e alle donne nati qui di non “spezzare le radici”, ma di prolungarle solo per brevi periodi. Non vi è altra strada che credere nelle possibilità della montagna, delle sue comunità, dei suoi giovani e delle sue imprese, di non rinunciare ad un percorso di sviluppo malgrado le numerose circostanze sfavorevoli e inique.
Maurizio Ionico
urbanista, ricercatore