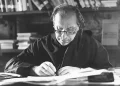Lo scorso anno, alla fine della sua gara olimpica a Parigi, la velocista afgana Kimia Yousofi ha mostrato il retro del suo pettorale. Vi aveva scritto tre parole, nei colori della bandiera del suo Paese: Education, Sport, Our Rights. Un gesto semplice, ma politico. Perché nello sport, piaccia o no, la politica è sempre presente.
C’è chi sostiene che la politica dovrebbe restare fuori dai campi da gioco. Che lo sport debba rimanere neutrale, immune dalle passioni e dai conflitti che attraversano la storia. L’idea è affascinante, ma profondamente ingenua e forse non così corretta come potremmo pensare. Lo sport, fin dalle sue origini, è sempre stato anche un fatto politico. Nella Grecia antica le poleis celebravano attraverso le vittorie olimpiche il proprio valore collettivo e i politici, non di rado, costruivano il proprio consenso a partire dalla partecipazione ai Giochi. Se guardiamo poi alla rinascita moderna del mito olimpico, ci accorgiamo di come l’azione di De Coubertin fosse tutt’altro che aliena da finalità politiche; egli, infatti, pensava lo sport come scuola di pace e di virtù civica. Cosa dire, poi, dei grandi eventi contemporanei, impiegati per affermare il prestigio di città o nazioni, ma anche per sostenere battaglie civili preziose come quella di Kimia? Pretendere che la pratica sportiva sia un’isola apolitica significa dimenticare la sua natura simbolica e comunitaria; ogni gesto atletico, infatti, possiede una valenza culturale, portatrice di valori, aspirazioni, visioni del mondo.
La questione vera, dunque, non è se sport e politica si intreccino, ma come. La storia mostra entrambi i volti: da un lato la strumentalizzazione – le Olimpiadi di Berlino del 1936, il doping di Stato, i boicottaggi durante la Guerra Fredda – dall’altro l’ispirazione, quando la politica si lascia educare dai valori sportivi. Penso a Mandela che usa il rugby per ricucire un Paese diviso, oppure ai Giochi Paralimpici come segno di inclusione e dignità.
Quando il potere piega lo sport ai propri fini, lo svuota; quando ne assume l’ethos – giustizia, uguaglianza, cooperazione – lo trasforma in palestra di umanità e di pace. Non dimentichiamolo: lo sport autentico nasce come confronto leale tra eguali, ricerca condivisa di eccellenza, rito di riconoscimento reciproco. L’avversario non è mai un nemico, ma un compagno necessario. Senza di lui, non c’è gioco. È questa logica della cooperazione che precede e fonda ogni confronto agonistico e che rivela la verità profonda dello sport come linguaggio universale di fraternità.
Alla luce di tutto questo, come leggere la controversia sulla partita tra Italia e Israele? Ridurla sbrigativamente a un sì o un no rischia di semplificare troppo. Io credo che questo confronto, così inevitabilmente segnato da valenze politiche, avrebbe senso solo se diventasse occasione per un messaggio forte, lanciato con una sola voce da tutti i giocatori: la condanna di ogni violenza, la richiesta di pace e giustizia, la memoria delle vittime, la liberazione di tutti gli ostaggi (ebrei e popolazione palestinese), l’invocazione di un’umanità riconciliata. Ma se queste condizioni mancano – e oggi, purtroppo, sembrano mancare – il rischio di lanciare il messaggio sbagliato è altissimo. Giocare “come se nulla fosse” potrebbe suonare – e molto probabilmente essere – una rimozione della tragedia in atto. Al contrario, sospendere la partita come strumento simbolico per chiedere la fine di ogni sofferenza potrebbe offrire un contributo. Minimo, forse velleitario. Ma l’alternativa sarebbe un silenzio complice.
Oggi più che mai, in un mondo lacerato da guerre e odi, il compito dello sport non è quello di tacere, ma di parlare un linguaggio universale di pace, amicizia, solidarietà, rispetto. Tuttavia, perché questo linguaggio sia credibile, deve essere incarnato, non solo proclamato. E qui sta il punto dolente. Le condizioni perché lo sport diventi segno di riconciliazione devono essere reali, non retoriche. Finché sui campi di battaglia si calpestano le regole dell’umanità, ogni celebrazione sportiva che ignora il grido delle vittime rischia di apparire come una nota fuori tempo. Questo non significa chiedere di fermare ogni competizione (se dovessimo attendere una pace perfetta, non si giocherebbe mai), ma esigere dalle istituzioni sportive un’assunzione di responsabilità politica e morale all’altezza dei valori che esse rappresentano.
Il sogno olimpico, ieri come oggi, ci ricorda che la vera vittoria è quella che si ottiene insieme, non una parte contro l’altra. Forse, più ancora che discutere se giocare o no una partita, dovremmo chiederci se siamo disposti a giocare davvero il difficile gioco della pace.
Luca Grion
Docente di Filosofia morale